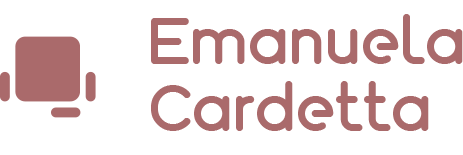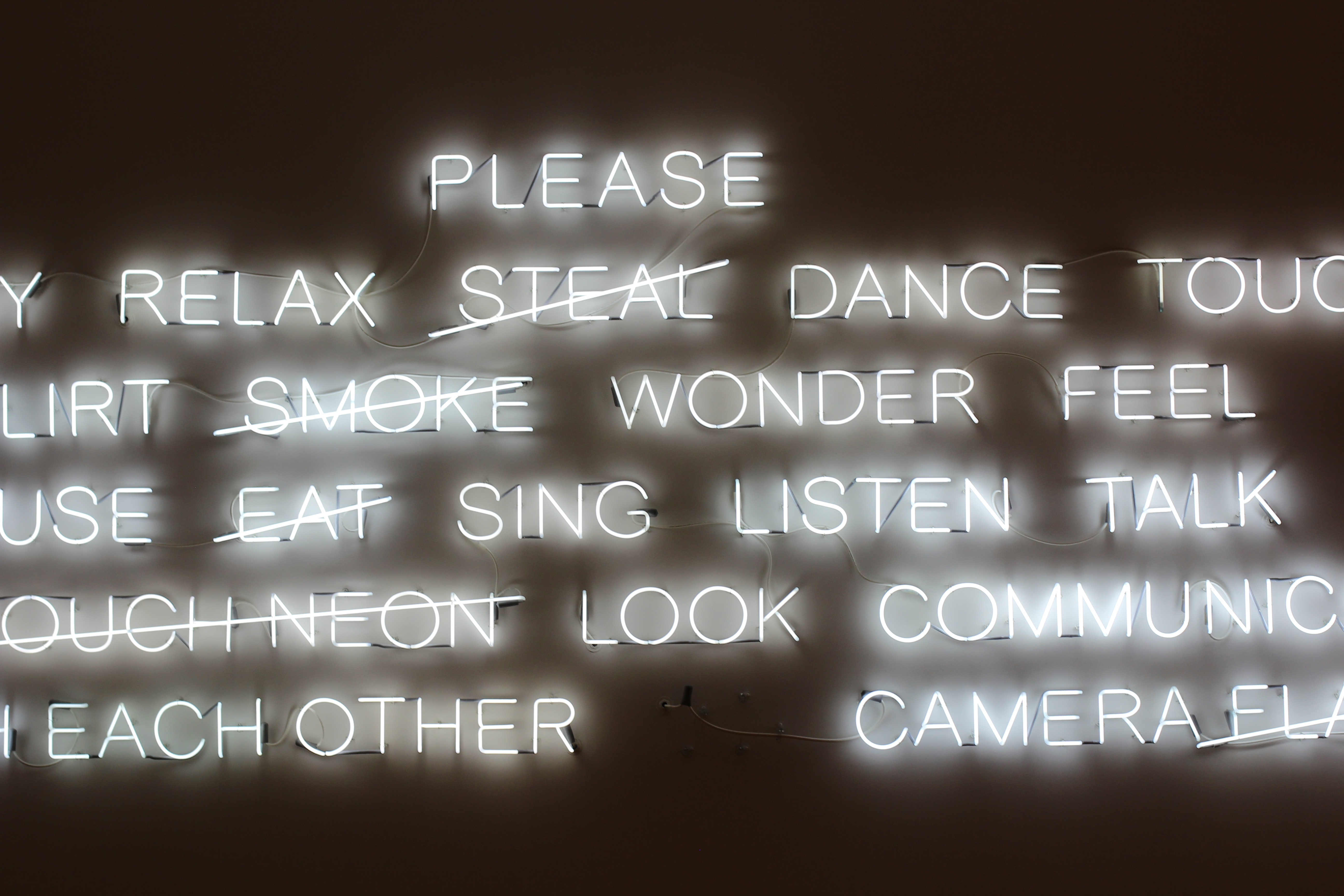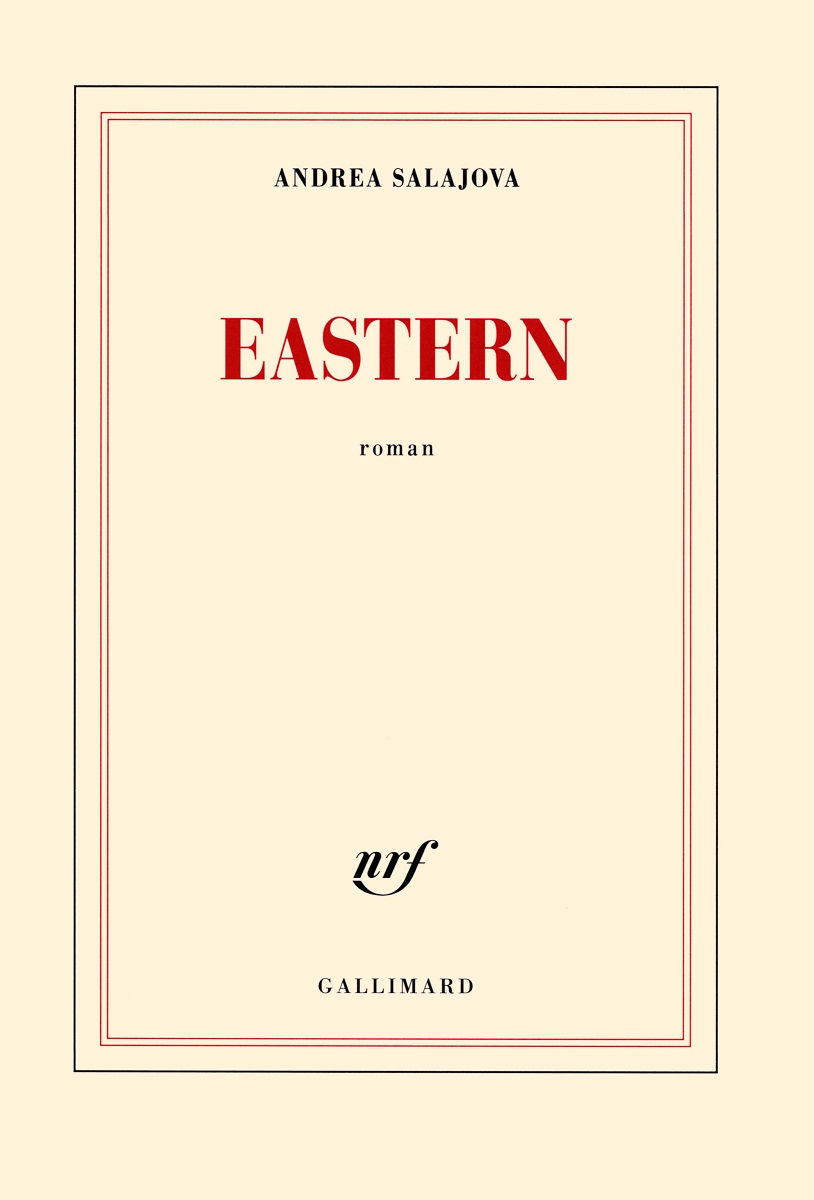Le interiezioni in slovacco
Le interiezioni, o esclamazioni, sono una delle parti del discorso e sono utilizzate per esprimere emozioni o stati soggettivi (qui la definizione completa del dizionario Treccani). In pratica sono quelle paroline che ci escono spontaneamente di bocca quando siamo sorpresi o scossi per qualcosa, colorando il...