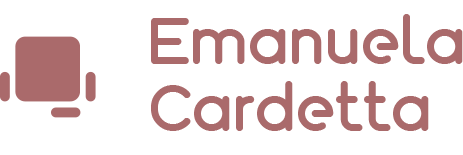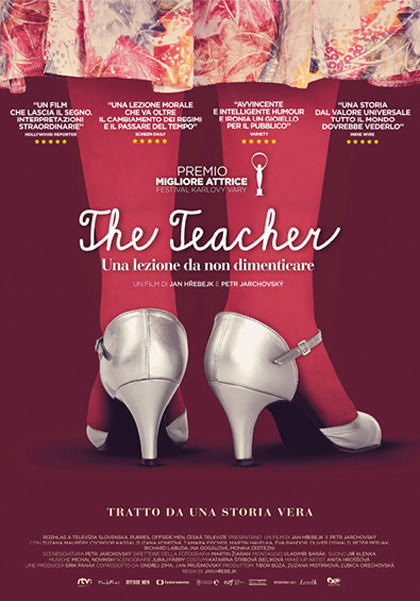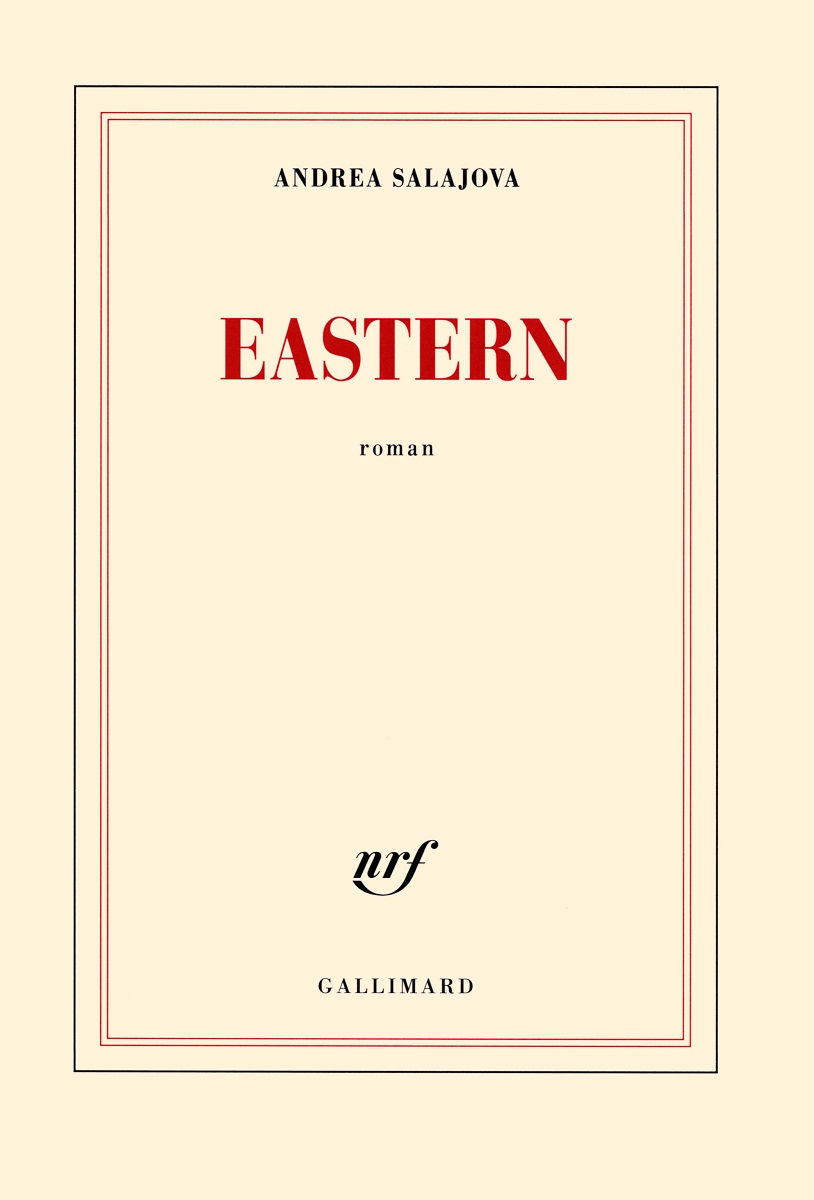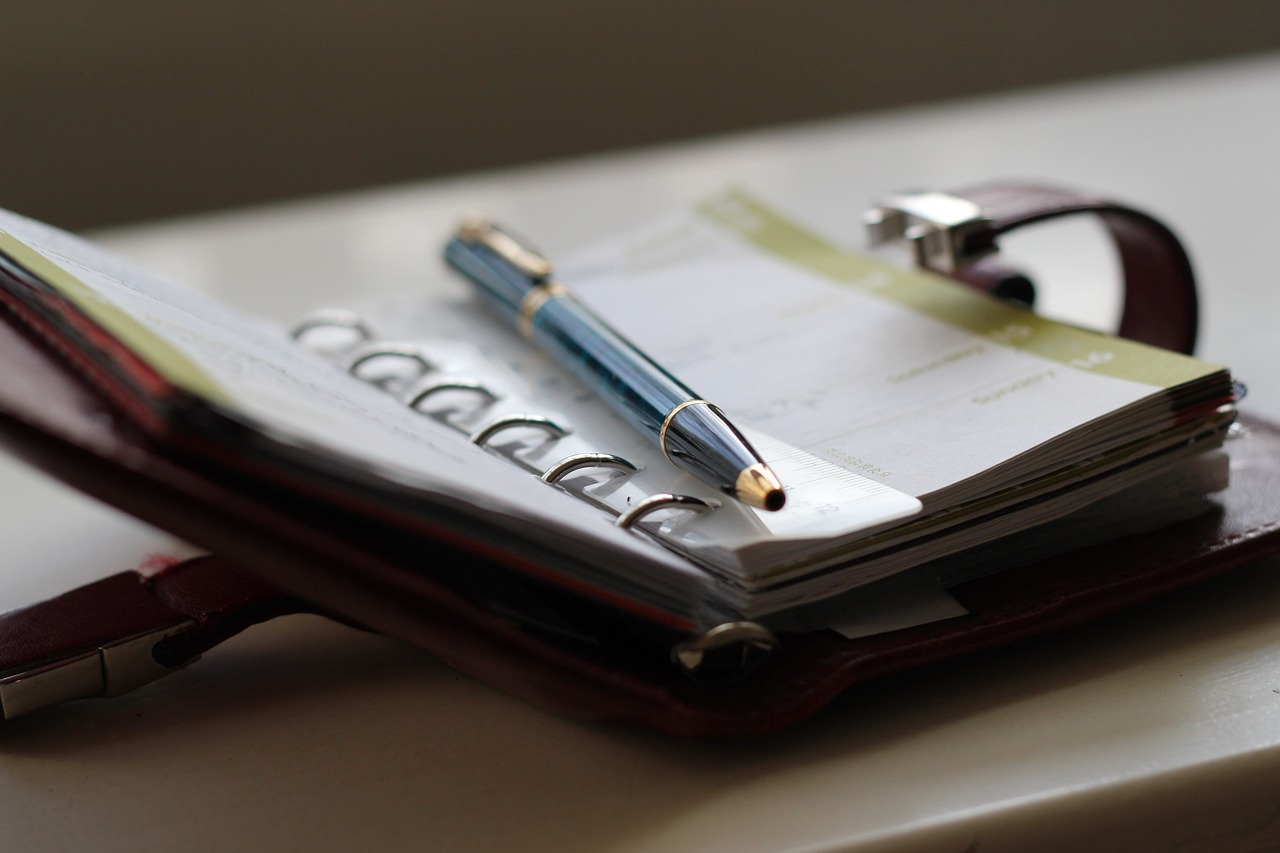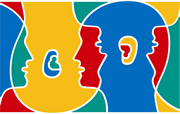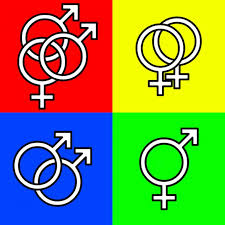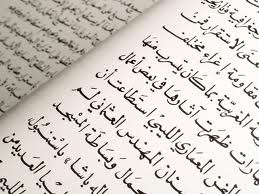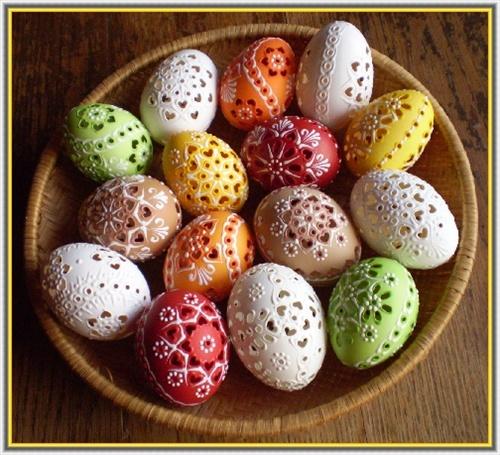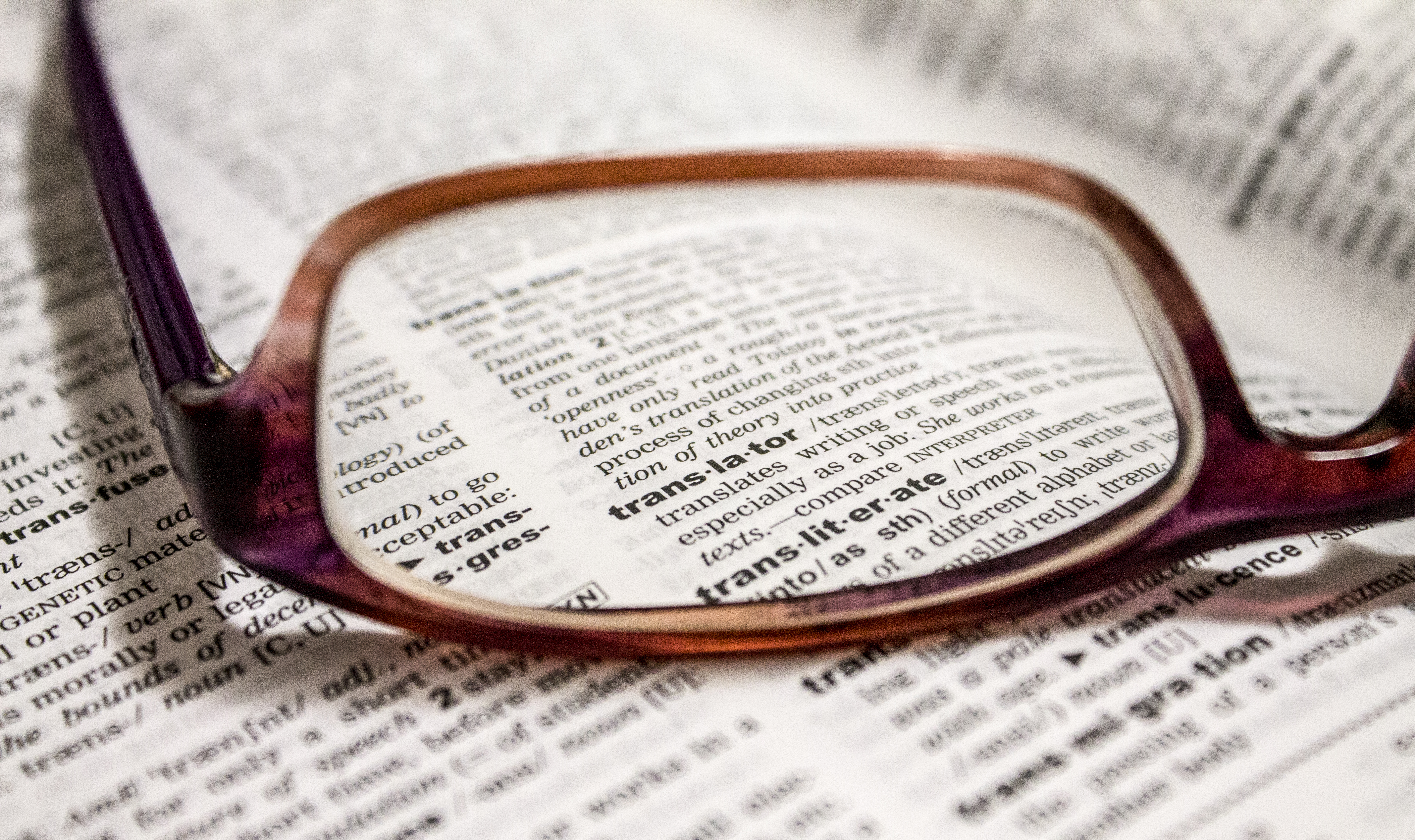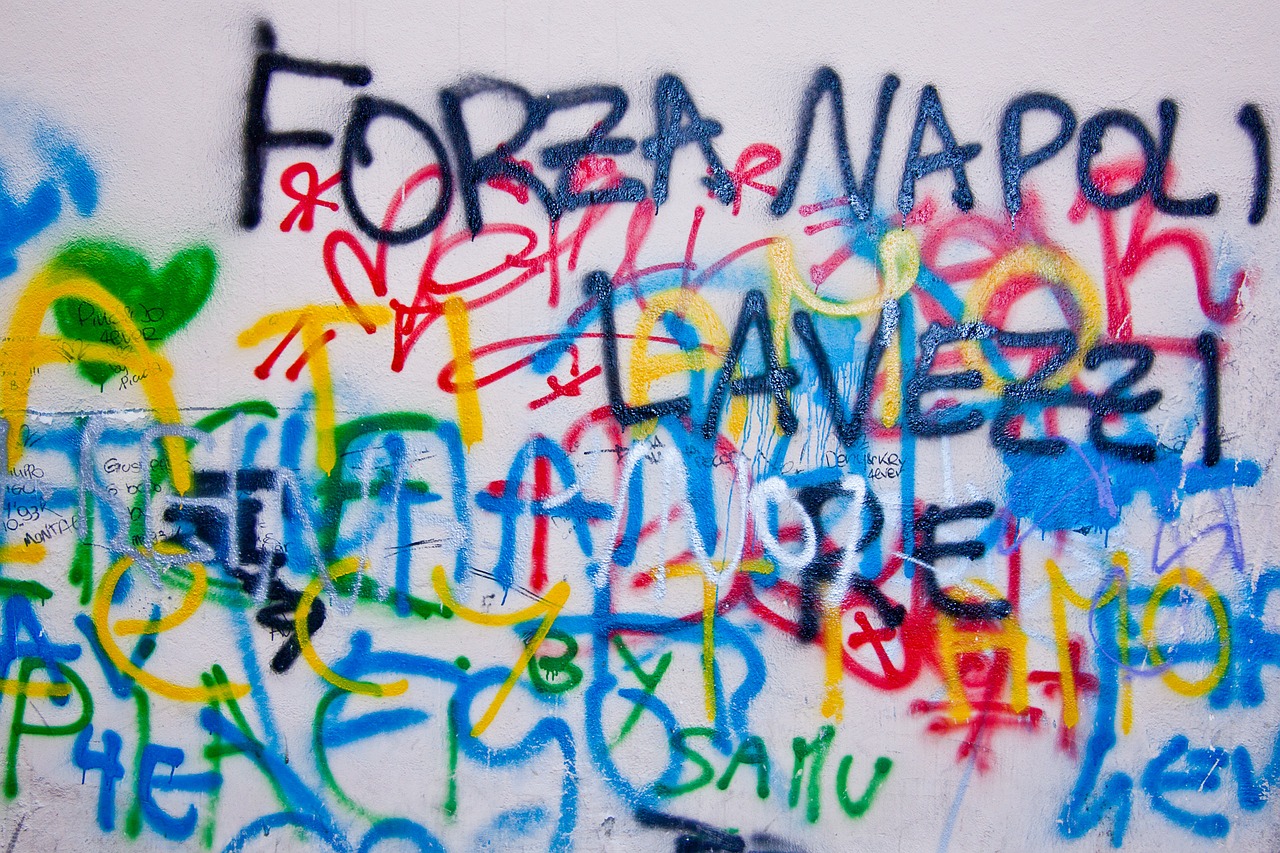Come si chiama la capitale dell’Ucraina?
Le terribili notizie degli ultimi dieci giorni hanno giustamente portato al centro della ribalta l'Ucraina. Ormai anche i non specialisti di quella zona del mondo hanno un'idea di dove si trovino le principali città del paese dell'Europa dell'Est. In particolare, i riflettori sono puntati sulla...