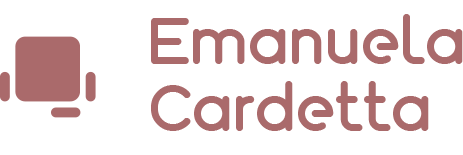Incidenti di percorso: la vicenda dell’interprete della premier Meloni alla Casa Bianca
Qualche giorno fa una vicenda che riguarda una collega interprete ha avuto un enorme risalto mediatico. La premier Giorgia Meloni ha incontrato il presidente americano Trump alla Casa Bianca per discutere della questione dei dazi e, al termine della riunione, i due leader hanno incontrato...