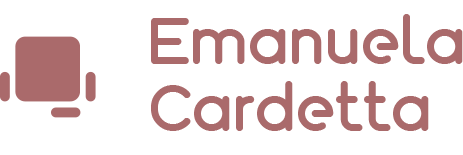Come prepararsi per una conferenza?
Lo studio preparatorio che precede una conferenza è sempre stata una delle parti che preferisco del lavoro di interprete perché puntualmente mi ritrovo con gli occhi sgranati sullo schermo per aver scoperto qualcosa di incredibile e per me assolutamente ignoto fino a quel momento. Oltre...