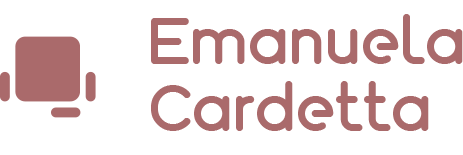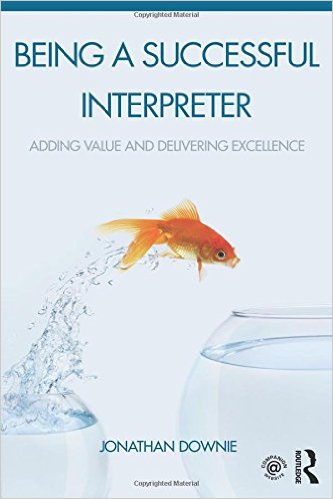Mi sento un cebo cappuccino
Una delle frasi che gli studenti di interpretazione si sentono dire più spesso dai docenti è senza dubbio: "Per fare l'interprete bisogna avere una vasta cultura generale". Nel corso degli anni, mi sono resa conto innumerevoli volte di quanto questo sia vero. Durante un convegno...